 Di Annito Abate
Di Annito Abate
Il programma del Master continua , prosegue la poliedrica visione della Campania del Vino, intra moenia ed extra moenia, raccontata, con piglio olistico, da 5 grandi attori, ognuno con la sua parte, ognuno con il suo carattere, una “rappresentazione” in 4 Atti + 1 per emozionare il pubblico degli appassionati:
• Primo Atto , Pierpaolo Sirch, in … “L’Agronomo”
• Secondo Atto, Luigi Moio, in … “L’Enologo”
• Terzo Atto, Manuela Piancastelli, in … “Il Comunicatore (le voci di “dentro”)”
• Quarto Atto, Piero Mastroberardino, in … “L’Economista”
• Atto Conclusivo, Armando Castagno, in … “Il Comunicatore (le voci di “fuori”)”
Secondo Atto: Luigi Moio, in … “L’’Enologo
Luigi Moio non ha bisogno di presentazioni, è uno Scienziato! Il suo curriculum, nella sua globalità, è la manifestazione più evidente del suo modo di pensare … e di agire!
Il foyer, come si addice ad un Grande Attore, è brulicante di persone che vogliono far sentire la loro presenza; la sala è piena, le luci più basse del solito, forse a far risaltare, ancor più, i contenuti che sarebbero stati “somministrati” sottoforma di immagini.
L’Enologo in purezza rimarca la sua formazione: «Sono laureato in Scienze Agrarie, mi sono occupato per anni di latte ed il mio incontro con il vino è una casualità e, contemporaneamente, una necessità derivata dalla promessa fatta a mio padre di curare la Cantina di Famiglia».
Luigi Moio, scende in “campo” con la determinazione di un difensore che marca ad uomo e pensa “Tu di qui non passi, oggi non ti faccio segnare!”: «l’uva è un frutto miracoloso che non si sarebbe mai trasformato in vino senza l’opera dell’essere umano, nella corretta interpretazione di “artificialità” riconosco a questo alimento anche un valore culturale ed emozionale». Con inesorabile evidenza l’Architetto del Vino stabilisce le sue “regole di laboratorio”: «E’ fondamentale la conoscenza dei fenomeni biologici e chimici e del loro controllo», poi rincara la dose quando afferma «Lavoisier concepisce il suo postulato fondamentale proprio sulla fermentazione alcolica». Insomma il vino per essere tale subisce trasformazioni che non avvengono in modo del tutto naturale, l’Uomo, infatti ne è “innesco” per mezzo dei lieviti, scelti, per il bene della “Scuola Enologica”, tra “i primi della classe”.
Sugli schermi compaiono alcune diapositive fitte di scritte, in rosso evidenziati i titoli, sono le pubblicazioni, gli studi, in gran parte condotti in Terre Transalpine: «Solo la Francia poteva darmi le possibilità di fare la carriera che ho fatto ed in tempi brevissimi. Aspettavo di restare in laboratorio per avere a mia disposizione tutte le attrezzature, per “testare” la verità delle mie ricerche». Immagino il giovane Moio rifiutare le scorribande proposte dai colleghi di studio, un’occasione bellissima per verificare nella pratica la teoria: degustare i vini buonissimi della Borgogna.
 Quello che sarebbe diventato un grande dell’enologia mondiale, non a caso, ha seguito la via della “degustazione teorica”, quella fatta di sacrifici, tesi, ipotesi, analisi e conclusioni. Un percorso enoico quasi “zen” fatto di esperimenti in vitro che ha portato, nel tempo, i migliori frutti, oggi anche sulle sue viti.
Quello che sarebbe diventato un grande dell’enologia mondiale, non a caso, ha seguito la via della “degustazione teorica”, quella fatta di sacrifici, tesi, ipotesi, analisi e conclusioni. Un percorso enoico quasi “zen” fatto di esperimenti in vitro che ha portato, nel tempo, i migliori frutti, oggi anche sulle sue viti.
L’esperienza francese diventa l’effetto terroir, un modello fantastico di studio dell’influenza del suolo sul vino ed il rispetto assoluto, quindi, dell’Appellation; la notion de terroir è, quindi, un percorso diretto che dall’uva arriva al vino, un’identità precisa e riconoscibile, ad esempio, della materia lignea, elemento tanto caro in Gallia.
Il primo messaggio fondamentale è che bisogna considerare il legno come uno strumento di stabilizzazione del vino, non di aromatizzazione.
Luigi Moio non dimentica di riattraversare le Alpi e decide di “entrare” nel Regno delle Due Sicilie: «In Campania i vini sono ancora poco noti; un tempo si compravano i litri di alcol presenti in un ettolitro di vino, la domanda di rito era “quanto fa di alcol”, o più semplicemente se era “buono o non buono”». In sostanza il vino era “anonimo”, semplice nella sua accezione non nobile del termine, la derivazione postbellica lo aveva portato ad essere considerato come un alimento corroborante dopo la fatica ed il duro lavoro.
Il primo dovere di un Enologo era “curare” il vino, un approccio tra la medicina e la chimica che non lasciava spazio ad altri indicatori di qualità ne gradi di libertà (nel “Primo Atto” anche Pierpaolo Sirch aveva posto l’accento su questo aspetto ricordando che l’Agronomo veniva considerato il medico dell’uva; si conferma un metodo, di oriental memoria, che tende ad imporre una vita sana basata sull’equilibrio per evitare la malattia all’origine rendendo inutile la cura).
Il famoso “gusto internazionale” è così affermato perché non è “anonimo” ma riconoscibile, piace perché ha una forte dominanza sensoriale, è varietale.
Il secondo messaggio fondamentale è rendere un vino “riconoscibile”, quindi, facilmente memorizzabile; questo obiettivo si può raggiungere soltanto attraverso la conoscenza approfondita degli aromi del vitigno, o dei vitigni, che lo generano.
Capire quali sono gli “odori” che rendono riconoscibile un vino, ovvero, avere a disposizione la sua carta d’identità sensoriale è una “guida” che porta la barra a dritta verso i lidi del successo.
«In Italia stiamo vendendo un territorio, il Vesuvio, l’Etna, la Costiera, la blasonata Toscana ed il Piemonte sono tutti potenziali Assessori al Turismo» racconta Moio, si ha però la sensazione di un “ma” che non tarda ad arrivare sottoforma di interrogativo «La Campania ha una piattaforma ampelografia storica invidiabile, un punto di forza che la rende riconoscibile; si può affermare, con certezza, che anche i suoi vini hanno la stessa identità territoriale o sensoriale?».
Nella Regione dei “Supetuscan” all’antica tradizione storica si è stratificata una grande operazione di identificazione indotta che, guarda caso, si è ispirata a Bordeaux, uno dei modelli più consolidati e riconoscibili del mondo.
Il Grande enologo, con enoica disinvoltura e sicurezza, utilizza la scienza, come ha sempre fatto, per supportare le sue tesi.
Esiste una dimensione oggettiva e misurabile (che si esprime attraverso i parametri chimico-fisici e le caratteristiche sensoriali) ed una dimensione soggettiva ed emozionale (che si esprime attraverso l’origine geografica e storica ed il legame con le tradizioni).
L’identità sensoriale si esprime attraverso l’aroma varietale, uno stimolo olfattivo che permette di riconoscere un vino e ricondurlo alla varietà d’origine della sua uva; questo legame può essere immediato (i profumi sono presenti già “liberi” nel vitigno) o “silente” (i profumi sono presenti nella cultivar ma ancora “legati”, prigionieri della natura che ha bisogno di trovare un modo per liberarli, “tu chiamali se vuoi … precursori aromatici “). «Il moscato è sempre moscato, indipendentemente da tutto, perché ha una fortissima identità varietale» dice lapidario Luigi Moio; infatti questo vino-vitigno si esprime con caratteri omogenei in ogni aspetto (uva, mosto, vino), il trebbiano, ad esempio, ha necessità che i suoi profumi si liberino per esprimere il suo carattere (ed aggiungerei, ha bisogno di grandi interpretatori) ed è per questo che non si può sbagliare, ogni parte deve contribuire all’armonia dell’insieme.
Nel vino con forte identità varietale c’è un solista che guida la sinfonia, viceversa, in presenza di vini con debole identità varietale c’è bisogno di una totale intonazione perché manca un “leitmotive dominante”: «l’orchestra deve essere perfetta perché se un musicista stona rovina tutto» spiega l’Enologo che auspica un modello sensoriale preciso e non una “mutazione” dell’identità di anno in anno.
Il terzo messaggio fondamentale è ridurre la variabilità, far emergere la corretta “varietalità” per tendere, quindi, alla riconoscibilità, che è uno degli indicatori di qualità e “successo” del vino.
Tornando in Regione Luigi Moio ammette che, tra le varietà a bacca bianca presenti sul territorio, Falanghina, Fiano e Greco hanno una marcia in più rispetto alle altre; la prima si esprime con note balsamiche e si può definire lo chardonnay della Campania ma solo per la sua adattabilità, la seconda con sentori floreali e la terza con un quadro odoroso più fruttato e con un colore più carico e caratteristico (io aggiungerei che il dosaggio della mineralità, oggi, se la gioca in fatto di stile ed interpretazione).
Il potenziale varietale non va perduto, pertanto in vigna tutti gli acini devono essere perfetti e molta attenzione va posta nella scelta corretta dell’esatto momento della vendemmia che deve essere tanto più preciso quanto minore è l’identità varietale dell’uva; le chiarifiche sui mosti possono far perdere i precursori aromatici, asportando, in pratica, gli odori, un’eccessiva surmaturazione, ancor più un appassimento, cambia completamente il quadro aromatico, “tu chiamala se vuoi … perdita di terpeni”.
Il quarto concetto fondamentale è che i vini, in genere, risultano omologati per difetto di odore, per mascheramento dell’aroma varietale, “tu chiamala se vuoi … genesi di off flavours”.
Circa i rossi, Luigi Moio non ha dubbi, l’identità varietale si esprime al massimo nel pinot Nero, Merlot e Cabernet; ovviamente il discorso non può non scivolare, a livello locale o quasi, sull’Aglianico e sulla sua componente tannica che si cela tra buccia e vinaccioli e che va “cavalcata e domata” chiedendo una forte mano al tempo: «nel Vulture è meno concentrato, a Taurasi più floreale perché più “diluito”». La macerazione corretta non dipende dai giorni trascorsi ma da quello che si ha intenzione di estrarre. Ma qual è il modello di tipicità, un aglianico tradizionale o un aglianico sperimentale?
In riferimento all’adattamento al mercato non sempre si riscontra una coerenza tra il modello sensoriale “ricercato” e quello che dovrebbe esprimere l’identità sensoriale: «è una contraddizione dire che una DOC deve andare incontro al mercato », figuriamoci una DOCG aggiungerei.
La Campania è una terra di grandi vini, dalle potenzialità straordinarie, ma non sembra ancora capace di esprimere compattezza ed unità di intenti, si dovrebbe affermare un più adeguato concetto di “vocazionalità” e tendere alla diversificazione delle produzioni per zone omogenee.
Un esempio è l’Asprinio che poteva esprimersi in una tipologia precisa ed affine alla sua personalità diventando “il Prosecco della Regione”, magari accompagnato da una adeguata campagna pubblicitaria (chissà se non siamo ancora in tempo a mandare un messaggio alle Istituzioni e farla finanziare, ma poi bisognerebbe anche convincere i produttori a cambiare registro e mentalità convincendoli che esiste anche un “diradamento” culturale che fa bene al terroir.
 Un altro caso è quello del Piedirosso, un grande vitigno che andrebbe vinificato diversamente per proporre un vino declinato sulle leggerezze, sul minor calore alcolico, diventando piacevole e beverino, magari più scarico di colore (il pensiero va al Nerello mascalese che nelle degustazioni alla cieca vien voglia sempre di inserirlo come intruso tra pinot noir ed altre varianti enoiche assimilabili per grandi linee).
Un altro caso è quello del Piedirosso, un grande vitigno che andrebbe vinificato diversamente per proporre un vino declinato sulle leggerezze, sul minor calore alcolico, diventando piacevole e beverino, magari più scarico di colore (il pensiero va al Nerello mascalese che nelle degustazioni alla cieca vien voglia sempre di inserirlo come intruso tra pinot noir ed altre varianti enoiche assimilabili per grandi linee).
Il quinto concetto fondamentale è dare un’identità ai vini della Campania, assecondare la marcia in più di alcuni vitigni e valorizzare gli altri; un tema da approfondire, ad esempio, è come trovare il “genius-eno-loci” nell’area vasta di Partenope.
Prima della degustazione Giovanni Ascione, con demiurgica capacità, estorce all’Enologo una sua opinione sui vini naturali, ed anche un sorriso (ci giurerei sarcastico): «trovo l’uso di questo termine improprio in quanto il vino è un prodotto innaturale, c’è malafede nella volontà di accattivarsi una fetta di consumatori», poi incalza: «avete letto i disciplinari del biologico?» e sferra il colpo finale ricorrendo alla sua grande preparazione, questa volta soprattutto quella chimica: «si ricerca la natura in etichetta e si permette l’uso del polistirolo nel packaging che contiene stirene, un idrocarburo aromatico estremamente cancerogeno».
Luigi Moio ribadisce a tutti che il vino è un progetto che parte dall’impianto in vigna e poi, assecondando i cicli vitali annuali della pianta, va dalla dormienza invernale alla vendemmia per arrivare alla vinificazione; l’analogia è con il termine francese “elevage” in rapporto al ruolo assunto dal tempo.
Il sesto concetto fondamentale è che il grande vino deve invecchiare rimanendo giovane.
Ed è proprio quest’ultimo concetto che avvalora le teorie del Grande Enologo con una conferma pratica sul campo rappresentata dai due sorprendenti vini portati in degustazione direttamente dal suo Quintodecimo, “creatura” nata nel 2001 a Mirabella Eclano in Provincia di Avellino: “Via del Campo 2009 Falanghina Campania IGT” e “Terra d’Eclano 2007 Irpinia aglianico DOC”.
Due “campioni” nel vero senso della parola che mi hanno fatto compagnia per gran parte del viaggio di ritorno, “tu chiamala se vuoi … persistenza”.
Ancora uno “spettacolo” eccezionale che ha lasciato tracce nel cuore e nella mente, tra poco il Terzo Atto per ascoltare “le voci di dentro”!
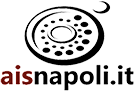
Scrivi un commento