Di Mauro Erro

La zona di Barolo è sempre stata caratterizzata, ad esempio, da una serie numerosa di minuscoli particolari, ancor oggi l’estensione media delle varie proprietà vitate ammonta a poco più di un ettaro e mezzo. Questa situazione, che ebbe origine a partire dal XVIII secolo, fu sicuramente acuita, intorno alla metà dell’Ottocento, dalla “famosa” Legge Siccardi, la quale attraverso l’espropriazione, ed in seguito la messa in vendita delle proprietà degli ordini religiosi, permise a molti contadini di divenire piccoli proprietari. Da non dimenticare, tra l’altro, lo smembramento di parte del grande patrimonio (circa 1200 ettari, non tutti vitati) dei marchesi Falletti, operato, dopo la morte nel 1864 di Giulietta Colbert, dall’Opera Pia Barolo per mantenere i numerosi enti caritatevoli fondati dalla nobildonna.
Veniamo ora al vitigno, il nebiolo, come si ostina a chiamarlo Baldo Cappellano (la doppia b verrà introdotta solo dal 1962 dal Ministero dell’Agricoltura in uno studio ampelografico) è vitigno estremamente difficile da trattare, coltivare e vinificare. Le quattro sottovarietà da sempre presenti nell’Albese – Lampia, Michet, Rosè e Bolla (quest’ultima proibita dal vigente disciplinare a causa della sue eccesiva produttività e di conseguenza scarsa qualità) – hanno un lunghissimo ciclo vegetativo che ne determina l’estrema delicatezza e sensibilità ai capricci del clima, dal momento che, il vitigno, fiorisce precocemente, già nella prima decade di aprile, e porta i grappoli a maturazione assai tardi, tra la prima e terza decade di ottobre. Essendo dotato, poi, di un grande ed esuberante patrimonio di tannini, ma non altrettanto di antociani, è complicato ottenere colore e, soprattutto, estrarre le due componenti fenoliche in maniera equilibrata per far sì che leghino in maniera adeguata a garanzia di un’opportuna stabilità nel tempo. Ma se ben accudito, è proprio il suo lungo ciclo di crescita e maturazione, che gli consente di accumulare ed elaborare, oltre gli zuccheri, una serie di sostanze che, dopo una sapiente fermentazione ed elevazione, ritroveremo nel vino in una complessa armonia di sublimi sensazioni.
Prima di arrivare al terroir, fondamentale fattore quando si parla di Barolo, è meglio sfatare, o chiarire, alcuni luoghi comuni che riguardano questo vino. Si è soliti oramai da tempo indugiare fin troppo nella distinzione tra produttori “tradizionalisti” e “modernisti”, senza tener conto di come nella lunga storia delle Langhe, questa distinzione sia fatta di sfumature e di come scapolare da una parte all’altra può essere, senza neanche rendersene conto, estremamente facile. Pochi, parlando di botti, forse sapranno che fino alla metà del Novecento le botti impiegate nelle Langhe erano costruite con legni locali, principalmente castagno o quercia, e che le dimensioni erano molto varie e dipendevano, come è naturale, dai quantitativi di uva lavorati nelle varie cantine: i piccoli contadini impiegavano, ad esempio, piccoli fusti da cinque o sette ettolitri. Quasi ogni paese aveva un suo bottaio, forma di artigianato ora pressoché scomparsa. A partire poi dagli anni Cinquanta, vennero sempre più utilizzate le grandi (da 30 fino oltre i 100 ettolitri) botti di rovere di Slavonia: i legni nuovi, prima dell’uso, venivano trattati con acqua, sale ed in seguito lavati con vino, per evitare che trasmettessero le loro essenze al contenuto, il che all’epoca, era considerato un difetto! Arriverà poi il momento dei legni francesi. Anni avanti altri mugugni si sono levati (intorno agli anni sessanta) quando in cantina cominciarono a comparire le prime pigiadiraspatrici, le vasche in acciaio, oppure, quando nello stesso periodo, Renato Ratti spiegò come, volendo superare le difficoltà del mercato, fosse necessario produrre un Barolo che “invecchiasse senza perdere le sue doti di freschezza”, iniziando a ridurre i tempi di macerazione. Oggi come oggi, non è difficile trovare nelle cantine di produttori che si è soliti definire “tradizionalisti” rotomaceratori, usati sì con parsimonia, ma pur sempre utilizzati.
Ed eccoci, finalmente, al terroir, “un’entità concettuale che ancora nel nostro paese si è capita poco (o non si vuole capire) perché scomoda e fastidiosa” citando Gigi Brozzoni, autore del libro “100 Barolo” edito da Gowine da cui sono tratte gran parte delle informazioni che ho scritto. Risale al 1929 la prima classificazione che si possa definire scientifica ad opera di Ferdinando Vignolo Lutati che nella suo saggio “Sulla delimitazione delle zone a vini tipici” – un lavoro durato più di vent’anni – studiò e censì i suoli e i vigneti di nebbiolo. I risultati del suo lavoro (Lutati divise la zona di Barolo in tre distinte sottozone) sono, grossomodo, ancor validi, anche se l’ultimo e recente studio, risalente al 2000, di zonazione ad opera della Regione Piemonte (Carta delle Unità delle terre di Barolo, da cui è tratta la foto) è giunto ad identificare fino a nove distinte formazioni geopedologiche. Per semplificare, divideremmo i territori in quattro macro-aree.
I suoli di quest’area, che furono originariamente fondali marini, si sono originati per il ritiro delle acque dal golfo padano nel Miocene Medio Inferiore (da 10 a 4 milioni di anni fa) e successivamente sono stati modellati e rielaborati dagli eventi climatici e sismici che si sono succeduti sino ai giorni nostri. Cronologicamente sono emersi prima i suoli ad est e successivamente quelli ad ovest seguendo la cronologia dei periodi Langhiano, Elveziano, Tortoniano e Messiniano. Tra la fine del periodo Langhiano e l’inizio di quello Elveziano iniziano ad emergere i suoli di Serralunga d’Alba caratterizzati da formazioni di Lequio con strati di marne grigie alternate ad arenarie formate da sabbie silicee più o meno cementate. È sicuramente la zona dove tradizionalmente vengono prodotti i Barolo più longevi e potenti che abbisognano di maggior periodo di affinamento prima di potersi esprimere nella loro eleganza e finezza, basti pensare alla Vigna Rionda o al detto in uso tra i fan del celebre (e costoso) Monfortino dell’azienda Conterno, secondo cui stapparne una bottiglia prima della maggiore età (18 anni dalla vendemmia) sarebbe un peccato mortale (per la precisione, fino al 1974, alle uve provenienti da Serralunga venivano unite quelle proveniente dal cru Le Coste. Dal ‘74 in poi le uve provengono solo ed esclusivamente dal vigneto Francia). Più ad Ovest, in pieno periodo Elveziano, emergono i territori di Monforte e Castiglione Falletto; i terreni hanno già una composizione differente, strati di sabbia più o meno compatta si alternano ad arenarie grigie (sabbie compattate e cementate da carbonati delle acque marine) dette Arenarie di Diano. Entrando nel Tortoniano (la zona che va da Barolo a sud-ovest verso Novello, a nord-ovest verso La Morra, e ancora più a nord fino a Verduno) il suolo è costituito da marne grigio-bluastre, ricche di carbonati di magnesio e manganese, che in superficie, in seguito dell’azione degli agenti atmosferici, diventano di tonalità grigio-biancastra: si tratta di argille miste a sabbie finissime, impregnate di una forte componente calcarea, che prendono il nome di Marne di Sant’Agata. Infine, all’estremo Nord-Ovest, area convenzionalmente compresa nel Tortoniano, la situazione geologica muta ancora nettamente, trattandosi di un suolo originatosi nel più recente periodo Messiniano e caratterizzato da una formazione gessoso-solfifera: prevalendo le sabbie sulle marne di Sant’Agata, si otterranno, in generale, quei Barolo giocati più sull’eleganza, sui profumi delicati, sulla finezza, che sulla struttura tannica e sulla potenza.
Siamo giunti alla fine, è ovvio che, oltre al carattere che deriva dal suolo, per quanto concerne il risultato organolettico finale dovremo tener conto di altri fattori tra i quali il singolo cru, l’altitudine, l’esposizione, i sesti d’impianto, le rese per ceppo, le pratiche enologiche e cosi via: ma ora non vi rimane che passare dalla teoria alla pratica, recarvi nella vostra enoteca di fiducia, e farvi consigliare un’unica ed irripetibile bottiglia di Barolo ed iniziare il vostro viaggio tra le Langhe, un viaggio senza fine in compagnia del re dei re.
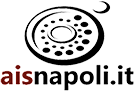
Mauro è capace di dotare il desiderio con gli strumenti acuti della conoscenza. se godere di un vino è anche saperne, allora qui siamo a scuola…
Grazie Luca, grazie tante, ma sei fin troppo buono.
E poi quando parliamo di Barolo non si finisce mai di imparare, e di bere…vivaddio.
La distinzione tra tradizionalisti e modernisti non mi sembra un luogo comune nè ancora del tutto sorpassata. E’ stata sicuramente abusata e forzatamente translata in altre zone (vedi Taurasi e Brunello) ma mi sembra ancora un necessario riferimento per poter inquadrare stili produttivi e vini. E’ verissimo quanto tu dici sull’uso, ad esempio, dei rotomaceratori da parte di molti che si definiscono tradizionalisti così come andrebbe sottolineato che diversi produttori talvolta vinificano alcuni cru in stile moderno ed altri in stile decisamente più tradizionale. Altri ancora sono riusciti in un’impostazione moderatamente e meditatamente moderna attraverso l’impiego intelligente della barrique e della tecnologia. In questo senso se da un lato sono d’accordo sul fatto che andrebbero evitate generalizzazioni dall’altro sono convinto che rimanga, comunque, un fattore imprescindibile per capire cosa è successo in Langa in questi ultimi anni e potersi correttamente approcciare ad etichette e produttori.
Hai pienamente ragione. Volevo solo dire che la distinzione può non essere così netta e che nel lungo corso della storia langarola vi sono stati comunque dei cambiamenti, dai legni ad altre pratiche di cantina: talvolta, ad esempio, io userei la parola “classicista” piuttosto che “tradizionalista”. Se pensiamo al 1961 (straordinario) di Borgogno bevuto durante l’ultima serata dell’eno-laboratorio non possiamo dimenticare che sia stato affinato in solo cemento e che non abbia visto legni.
Caro Mauro,
l’altra sera sono stato molto bene, c’è molta cura nei vostri “mini simposi” e mi congratulo con i tre organizzatori.
Ho mmolto apprezzato il tuo intervento che conserverò con cura per la ricchezza di nozioni tecniche e storiche, tuttavia non sottovaluterei il problema che esiste da una decina di anni tra i produttori della Langhe. E’ un problema che si avverte nelle vinerie di via Barbaroux, di via XX settembre, frequentate soprattutto da giovani, ai loro tavoli non trovi mai i baroli, i barbaresco, nelle loro ordinazioni ci trovi la freisa, il dolcetto, il grignolino, la bonarda, la barbera ed i nebbioli vari. Costano di meno, hanno una beva più semplice, sono insomma in genere meno “impegnativi”, il mercato oggi è quello ed ha generato una rivoluzione nelle aziende storiche ed una rivisitazione dei procedimenti di vinificazione dei “grandi rossi” creando malumori e molte altre difficoltà corredate. Credo insomma sia un problema ancora molto sentito.
Grazie Franco,
giro prontamente l’apprezzamento per il tuo contributo alla serata, in pieno “stile eno-laboratorio”, che ho molto apprezzato. Venendo al dunque, credo che Fabio abbia colto il senso: evitare generalizzazioni che possano divenire luoghi comuni. In una generale disamina storica non si può non sottolineare come siano tante le sfumature.
Poi, a bocce aperte e calici riempiti, si andrà nel particolare: particolare, ad esempio, che mi vede convinto bevitore, come te da quanto ho potuto capire, dei Barolo – di quel rigore e di quell’austera eleganza – che direi “classici”.
Caro Mauro, il viaggio nelle Langhe l’ho fatto davvero, mentre tu te ne stavi nei Paesi Bassi :)
Le aziende che ho visitato oltre ad essere tradizionaliste per l’uso dei legni (il massimo concesso per uno solo dei produttori a cui ho fatto visita era un tonneaux usato, per ragioni di spazio, appena per la sosta di una piccola percentuale ad integrare la stragrande maggioranza che entrava in botti dai 50hl in su) non adottano di certo rotomaceratori, ma tutti effettuavano una classica fermentazione con rimontaggio (Cavallotto, Cappellano, Rinaldi, Maria Teresa Mascarello, Monchiero…).
Naturalmente, esistono le sfumature, come anche Fabio ha sottolineato. Ma è giusto così, specie in un comprensorio in cui ogni famiglia è produttrice di vino. poi i distingui, è chiaro, li si fanno volta per volta (a proposito, credo che Borgogno ora utilizzi anche rotomaceratori, ma in misura non invasiva…)
Luigi non è mia intenzione essere polemico, figurati poi nei tuoi riguardi ma non penso che si possa parlare di utilizzo di rotomaceratori in maniera non invasiva… Se vuoi dire che anche utilizzando dei rotomaceratori si possono fare degli ottimi Barolo, in stile forse meno classico e tradizionale ma comunque dei vini validi sono perfettamente d’accordo con te. Ma l’impiego di un rotomaceratore anche se non invasivo è di per se determinante, accorcia notevolmente i tempi di macerazione ed il risultato non può che essere diverso.