
Migliore l’idea, l’intuizione della sua realizzazione concreta, questo si può dire, in sintesi, della prima edizione di WineCreator primo international meeting o, per dirla in spagnolo “encuentro de autores de vino”, che si è svolto a metà aprile nella splendida antica cittadina di Ronda (vedi filmato), a nord di Malaga nel cuore di un’affascinante Andalusia. La trovata di mettere per due giorni a confronto, in diverse sessioni di dibattito, chi il vino lo progetta, contribuisce a crearlo, lo produce, ovvero i vignaioli ed i produttori ed i loro preziosi consulenti che con termine inglese siamo soliti definire winemaker, e chi il vino lo racconta, lo giudica, lo analizza, lo propone e ne canta le gesta al consumatore, ovvero la stampa specializzata, era davvero originale e avvincente, soprattutto se si considera che chiamati a confrontarsi e a dialogare erano personaggi di assoluto rilievo, dal professor Denis Dubourdieu professore di enologia all’Università di Bordeaux ad un grande produttore di Porto come Dirk Van der Nieeport ad enologi come Michel Rolland (poi sostituito dalla moglie Dany) per tacere dei giornalisti, nomi come Jancis Robinson, Michel Bettane, Joel Payne, Pierre Casamayor o Joshua Greene. Eppure, nonostante gli sforzi del comitato organizzatore, che oltre a José Peñin dell’omonimo Gruppo editoriale e della celeberrima guida dei vini spagnola, comprendeva una serie di esperti, generalmente giornalisti, di tutto il mondo, ed in particolare del collega Victor de la Serna del quotidiano El Mundo, che ha svolto il difficile compito di moderatore del convegno, cercando di legare tutti i momenti della discussione con un ideale filo rosso, il dialogo si è rivelato piuttosto una conversazione a due voci e con linguaggi diversi dove ognuna delle due parti è sembrata intenta a rivolgersi a se stessa piuttosto che a cercare di interloquire con l’altro. Nel dibattito, difatti, anche se tutti hanno ribadito l’esigenza di perseguire la Qualità e di realizzare vini che esprimano tutte le potenzialità delle uve e dei terroir d’origine (ma allora i vini globalizzati, quelli che tendono ad essere tutti uguali, potenti, scuri, concentrati, redolenti di legno, massicci, senza eleganza, chi diavolo li produce e chi li giudica positivamente?) e che siano altrettante risposte in termini di bio-diversità alla minaccia di livellamento del gusto che arriva da un mercato sempre più vasto e globale, è stato difficile, oppure zigzagante e ondivago, cogliere lo sviluppo di un discorso organico che si ponesse come riflessione su quello che si deve fare e su quello che non deve essere più fatto.
Se nella prima sessione “vini di frutto o vini di radici? L’importanza del terroir in un buon vino” Van der Nieeport ha rivendicato il ruolo della creatività nel fare vino, importante quasi come il lasciare esprimere un processo naturale senza modificarlo, e Michel Bettane ha ricordato che “il successo di un buon vino è dato dal lavoro intenso dell’uomo”, mentre Joshua Greene, direttore della rivista americana Wine & Spirits ha ricordato come il terroir dia eleganza e carattere distintivo ai vini, il simpaticissimo produttore sloveno Ales Kristancic, deus ex machina di una cult winery come Movia, ha sottolineato che “ci sono vigneti avvantaggiati ed altri meno” e che “occorre cogliere il potenziale di partenza di una zona e di un vigneto, poi è questione di gusto e che il vero viticoltore si dà una strategia studiando i vigneti, la scelta dei vitigni adatti, il terroir, la quantità di acqua a disposizione, una strategia per sopravvivere ai vigneti e farli sopravvivere, ma il gusto personale del vino poi è fondamentale”, il resto del discorso si è sviluppato, spesso senza un filo logico conduttore, a sprazzi, con illuminazioni e accensioni seguite da cadute di tensione. Nella seconda sessione del dibattito “disegnare un vino “differente” sin dal vigneto. Può la gestione del vigneto contribuire a dare maggiore personalità al vino?”, rivelatorio e stimolante, il più lucido a mio avviso di tutto il convegno, è stato l’intervento del professor Dubourdieu, che partendo da una convinzione sorprendente, ovvero “non penso che i grandi vini siano stati prodotti esclusivamente dalla viticoltura”, e dalla persuasione che il vino sia “anche oggetto sociale e rappresentazione e fenomeno di civiltà”, ha sottolineato come nel vino “il piacere è fondamentale”, come sosteneva Molière, secondo il quale “è importante gustare senza annoiarsi”.
Oggi occorre rilevare, sempre secondo il docente bordolese, che molti vini ingenerano noia e stanchezza e questo alla fine finisce per generare disinteresse verso il vino. L’antidoto alla noia, anche nel campo del vino, non può essere pertanto che la complessità che fa intravedere il mistero e non può essere imitata perché esprime un’unicità. Per Dubourdieu la vera viticoltura è basata sulle difficoltà ed i vigneti che non presentano problemi nella loro gestione non assicurano complessità dei vini e “successo”. In fondo, ha detto, “la viticoltura è una variabile di adattamento per consentire di salvare un handicap”. Venendo alla peculiare situazione bordolese, che ben conosce, secondo il grande studioso “con certe varietà si è superato l’handicap climatologico” legato alla piovosità di Bordeaux, ma ricorrere come ad una ricetta al Merlot “che non permette di creare vini eccezionali” è “una soluzione troppo facile e banale” e occorre, a Bordeaux, come altrove, “saper vincere le difficoltà” per dare una personalità vera e inimitabile ai vini.
Secondo Dubourdieu la civiltà del vino mondiale ha radici in civiltà e culture differenti e pertanto “non è in alcun modo giustificato credere che per produrre grandi vini in un determinato terroir occorra, come una ricetta semplice, fare ricorso a vitigni che hanno dato grandi risultati altrove. La scelta delle varietà cambia in funzione dei mezzi economici e delle ambizioni. Occorre invece valorizzare il terroir ed il gusto locale e “prendere il rischio” di credere in determinate varietà che sono difficili e ci creano dei problemi, ma fanno la differenza”. Punto di vista non condiviso dal talentoso enologo e produttore spagnolo Alvaro Palacios, una delle stelle dell’emergente zona vinicola del Priorat, formatosi a Bordeaux, secondo il quale “la mondializzazione dei vini non è necessariamente da drammatizzare, perché consente di avere determinati vini per certe persone e certe situazioni” ed il trapianto, in Spagna, di varietà del nord nel sud, che in passato non funzionava ora dà risultati molto interessanti, anche se la personalità e la piena complessità è ancora da conseguire. Per Palacios la “viticoltura combatte le avversità della natura, i terroir devono essere lungamente elaborati nel tempo” e spostare una varietà da un Paese all’altro non è poi una scelta così drammatica, perché “in molti Paesi del mondo si fanno vini adattati al terroir”.
Constatazione realistica, anche se, ancora secondo Dubourdieu, “la differenza tra un buon vino ed un gran vino sta esclusivamente nel diverso livello di piacere del consumatore”. In passato, secondo lo studioso francese, “i grandi vini venivano pensati per il loro invecchiamento e apprezzati maturi. Oggi buona parte dei consumatori esige vini da bere giovani ed il vino, che è figlio del cliente e dei gusti del consumatore, ha dovuto adattarsi”.
A suo parere oggi “l’enologo è costretto a scegliere un certo tipo, forzato, di piacevolezza, se questa è richiesta dal mercato e puntare su una maturazione tardiva delle uve che enfatizza il carattere fruttato, ma penalizza la possibilità dei vini di evolvere nel tempo e di maturare compiutamente e sacrifica il carattere varietale”.
Punto di vista, quello del professor Dubourdieu, non condiviso, ovviamente, da Dany Rolland, moglie e collega (a sua volta enologa) di quel Michel Rolland, enologo consulente e flying winemaker per un centinaio di aziende sparse in diversi Paesi del mondo, ed esponente massimo secondo alcuni (ad esempio l’autore del celebre film Mondovino) di una filosofia interventista e globalizzatrice, secondo la quale “in passato le differenze nei vini erano soprattutto dovuti alla mediocrità e non alla qualità e “omogeneizzare” la qualità è segno di un’indubbia crescita qualitativa”. Per la signora Rolland i vini moderni comportano un “lavoro dolce sull’uva” e l’odierna evoluzione della qualità, che si è tradotta in un’enorme evoluzione tecnica, prevede “l’ottimizzazione dei terroir, per vendere bene” e rendere appealing il prodotto vino.
Un altro importante enologo francese presente al dibattito, Stéphane Derenoncourt (leggere qui cosa ne scrive Jancis Robinson) l’interventismo degli enologi, se esiste, consente loro “di avere più mezzi per fare un buon vino, cosa difficile da ottenere”.
Oggi, a suo dire, “il vino è diventato uno status symbol e molta gente è diventata ricca con il vino oppure gente ricca si è avvicinata al vino arrivando da altri mondi e altre logiche”, e condividendo lo scetticismo della wine writer anglo-russa (ma residente in Italia) Eleonora Scholes, sulla positività di un eccessivo interventismo degli enologi, Derenoncourt si è dichiarato “fiero di essere rimasto dietro l’etichetta” e di non aver indotto a parlare, come accade con altri suoi colleghi di “vini dell’enologo X o Y”. Il resto del dibattito, che si è sviluppato in altre sessioni, ha visto un andamento più confuso, con uno svilupparsi e focalizzarsi del discorso più rapsodico. Per Peter Sisseck, produttore del più mediatico e costoso vino spagnolo, Pingus nella Ribera del Duero, “è fondamentale il lavoro con uve diverse e le uve devono adattarsi al clima del posto”, per il giornalista americano, collaboratore del Wine Advocate di Robert Parker, ma anche di The World of Fine Wine, David Schildknecht, gli europei “tendono a lottare contro il concetto di tradizione nel vino” e “le tecniche del passato non erano studiate, ma semplicemente applicate” (seppure spesso con ottimi risultati), mentre per il collega messicano Rodolfo Gerschman, “rinnovamento e tradizione sono parole pericolose e oggi la figura dell’enologo tende ad intervenire più che in passato, con un’idea dell’intervento intesa come conoscenza applicata”.
A suo dire oggi la tradizione “tende a creare una nuova tradizione che diventa innovazione e recupero della tradizione: quale frontiera alla fine tra le due?”. Interrogativo ripreso e sviluppato ancora da Denis Dubourdieu, secondo il quale “la tradizione fa paura, ma il vino si fa con l’uva e non con le buone coscienze. L’innovazione va bene, ma solo se permette di salvare la viticoltura, di preservare la diversità varietale, di avere la meglio sull’insidiosa offensiva delle malattie della vite, che non si combattono con i buoni sentimenti”.
A WineCreator erano anche presenti due italiani, l’enologo Carlo Ferrini ed il co-curatore della Guida dei Vini dell’Espresso Ernesto Gentili, ed i loro interventi sono stati tra i più interessanti e lucidi. Per l’enologo toscano “le aziende pensano poco al mercato o ci arrivano in seguito e solo le grandissime aziende, dati i numeri che producono, devono tenerne conto in ogni fase”. A suo dire, replicando ad un intervento di Peter Sisseck secondo il quale “è assurdo che i giornalisti possano avere una forte influenza sui creatori del vino e occorre pertanto restare fedeli al terroir senza farsi condizionare dalla stampa”, “il vino, come qualsiasi oggetto di pregio, è soggetto alla concorrenza” e quindi “ci sono proprietari ed enologi che ignorano tranquillamente il parere della stampa, mentre altri si fanno influenzare dando vita talvolta ad episodi di complicità”.Ernesto Gentili ha invece preferito puntare sullo sviluppo di “diverse figure di consumatori negli ultimi 10-15 anni” e sulla progressiva evoluzione, in molti di loro, da uno stadio “primordiale” che tende a privilegiare il gusto dolce, la morbidezza, la rotondità nei vini, magari con una leggera “vena di boisé”, ad uno stadio successivo, più consapevole e maturo, dove “si cercano le sfumature, la complessità, la profondità, la personalità dei vini”.
Oggi, a suo dire, si assiste ad una riscoperta del “gusto complesso”, con uno spazio per tanti vini e mercati diversi. Scopo di WineCreator, pertanto, “dare uno stimolo a tutte le componenti del mondo del vino per pensare e valorizzare il concetto di diversità”.
La stampa, a suo dire, e non si può che concordare con lui, “non deve degustare con atteggiamento di routine, ma con grande curiosità intellettuale, senza affidarsi a modelli di vino rassicuranti ,ma rischiando un giudizio su vini più difficili e complessi”.
Sino a qualche anno fa, per Gentili, “i winemaker avevano una strada obbligata, colore intenso, concentrazione, potenza. Oggi ogni enologo deve avvertire la responsabilità di cercare di valorizzare e differenziare ogni singolo prodotto, senza applicare gli stessi sistemi e protocolli operativi”, questo anche perché il pubblico “è molto più esigente e attento al concetto di diversità”. Ferrini ha poi sottolineato “la grande difficoltà di produrre vini personali, perché per fare un grande vino servono come minimo dieci anni di tempo e grandi investimenti eppure il mercato ha fretta e non ha tempo per attendere la grande qualità”. Secondo Gentili “ognuno, produttore, enologo, giornalista, deve sforzarsi di fare bene il proprio lavoro, senza preoccuparsi di fare o scrivere quello che pensa l’altro si aspetti da lui. Il critico di vini deve esprimere con franchezza il proprio punto di vista, il winemaker interpretare al meglio ogni singolo territorio”. Il finale, dopo alcune osservazioni di Michel Bettane, espresse in una sessione aperta al pubblico, secondo il quale “tutti i grandi produttori hanno personalità e fanno il vino che vogliono senza farsi influenzare, ma il gusto cambia e lo stile può cambiare e anche i grandi vin de terroir possono evolvere e mantenere posizioni fisse non è segno di grande intelligenza”, è stata affidata, dopo un intervento riassuntivo dei due giorni di dibattito di Jancis Robinson, al grande giornalista francese ed enologo Pierre Casamayor. A suo avviso rincorrere l’idea di un grande vino equivale alla ricerca del Sacro Graal e “si gusta il vino pensando al lavoro da cui proviene. L’uomo è il direttore d’orchestra, che può prendere buone decisioni o cattive, ma quel che conta è il rispetto, nel vino, di una partitura data dal binomio uva-terroir. L’uomo, il produttore, non inventa la melodia, ma la esegue e questa melodia, data dalla natura, non può essere influenzata e se il produttore vuole raggiungere il top deve lasciar parlare la melodia, non essere mai protagonista”. Come non dargli ragione?
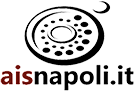
Scrivi un commento